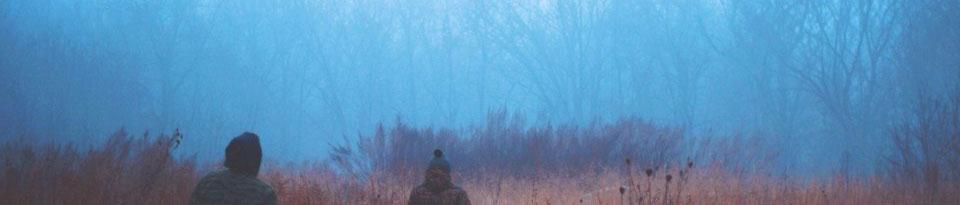Da una parte, infatti, mette quanti vivono, e concepiscono come “corretta” una sessualità “tradizionale” – uso questo termine per non cadere in equivoci – e dall’altra quanti vanno al di là della stessa. In pratica è un affermare che l’omosessualità non “tradizionale”, vissuta dunque come condizione anomala, diremmo eccezione alla regola, debba ricorrere ad effetti speciali, appunto quelli con i quali si manifesta nel “Pride”, per potersi esprimere e manifestare pubblicamente. Un evento, dunque, che ha funzione di esclusione piuttosto che di inclusione.
Inoltre, ci pare evidente che, nelle manifestazioni di questo tipo, ormai relegate come fenomeno culturale ad un rango secondario – hanno perduto a livello internazionale la propria incidenza e sono solo considerate come grandi fiere spettacolari – il filo rosso, conduttore, che si percepisce sia quello della sfida che, in poche parole, non si sostanzia solo nel “noi ci siamo”, fatto che non sarebbe censurabile, ma nella provocazione al mondo, chiamiamolo, convenzionale, agli stili di vita consolidati, al modo di essere della società considerati, nella migliore delle ipotesi, superati quando non, addirittura, fuori dalla modernità.
Proprio per questa sua carica provocatoria il Pride non concorre, almeno a nostro parere, al raggiungere l’obiettivo, ma determina, come conseguenza solo rotture di dialogo, incrinamento della comprensione e compromissione delle aperture. Fatti, questi, che non possono, certamente, rendere felici quanti, sicuramente meno di ieri visto che qualche passo avanti si è fatto, trovano difficoltà a far riconoscere come “non anormale” una condizione che viene ritenuta, dalla gran parte del contesto sociale, come invece non tale. Queste considerazioni ci portano, dunque, ad essere sostanzialmente perplessi sia sul giudizio che sulla produttività dello stesso evento come mezzo di affermazione di una “diversità” che ancora risulta emarginata.
Di Pasquale Hamel